OTTANTA ANNI FA IL VILE ASSASSINIO DI GIOVANNI GENTILE, SOMMO FILOSOFO ITALIANO NELLA SUA PIU’ PROFONDA ESSENZA.
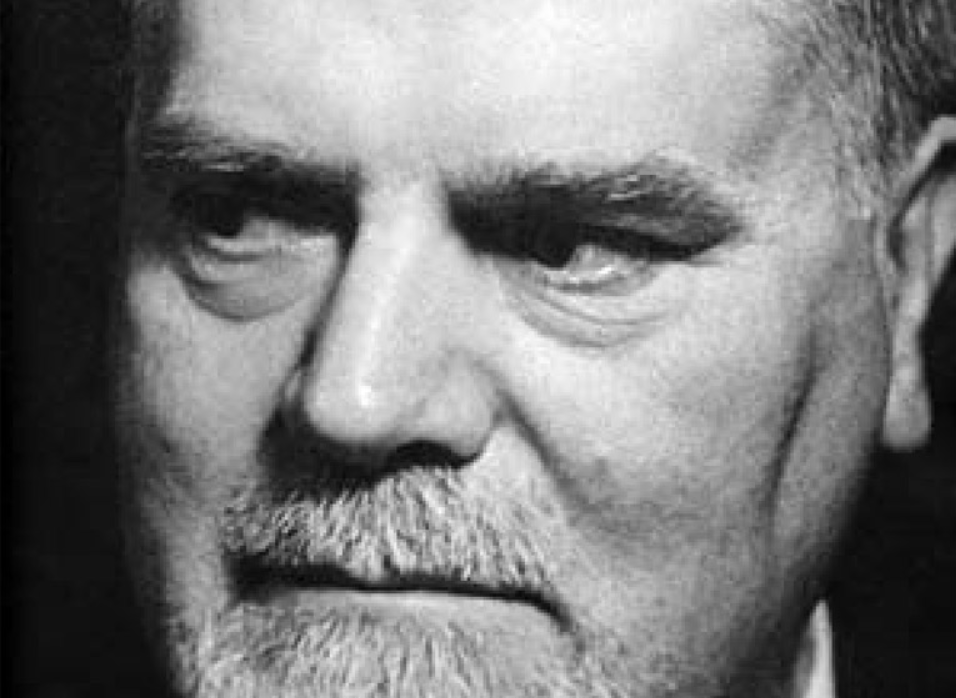
Il 15 aprile 1944, a Firenze, un commando partigiano comunista uccideva vilmente (i killers si finsero a lui sommo docente, studenti universitari postulanti con libri sotto braccio celanti le armi) il massimo filosofo italiano del Novecento assieme a Benedetto Croce; e tra i massimi di ogni tempo. Come illustre pedagogista, Giovanni Gentile fu autore di una riforma essenziale dell’ordinamento scolastico nel 1923, incentrata sulla supremazia morale e intellettuale del liceo classico, intatta per circa settanta anni prima che la visione gentiliana fosse offuscata dal mercantilismo globalista e materialista delle tre I berlusconiane (Impresa-Inglese-Informatica).
Giovanni Gentile fu anche il motore realizzatore della Enciclopedia italiana Treccani.
Di scuola hegeliana, come anche Benedetto Croce, Gentile declinò l’hegelismo diversamente in fenomenologia dello spirito e in gnoseologia, con esiti pratici totalmente divergenti: il filosofo partenopeo di origini abruzzesi restò liberale monarchico ma antifascista, il gigante del pensiero di Castelvetrano (altro che “paese di Messina Denaro”) fu nel primo governo Mussolini e divenne la colonna intellettuale del Ventennio.
La sua accademicità e linguaggio rigorosamente e tecnicamente filosofico, oltre che la mai consumata rottura mentale rispetto al mondo borghese e “occidentale”, me lo fanno trascurare solo rispetto all’ incandescente, eversivo, storicisticamente demolitore Julius Evola. Ma il rispetto e l’ammirazione, da italiano che ancora ritiene di dover imparare a pensare verso italiano maestro indiscutibile di pensiero, sono totali e senza alcun distinguo; come totale dovrebbe essere l’esecrazione verso mani omicide mandate e ispirate anche da altri accademici quali lo stalinista Concetto Marchesi, sommo latinista. Le sue spoglie riposano, giustamente a sommo onore, nel tempio nazionale di Santa Croce in Firenze.
Come già ricordato in un mio articolo sullo sbarco in Sicilia e i giorni che lo precederono, il 24 giugno 1943, nel sito straordinariamente evocativo del Campidoglio, Giovanni Gentile pronunciò forse il suo discorso più toccante, commovente e profondo (il cosiddetto “Discorso agli italiani”) che qui, in omaggio alla sua memoria, riproduciamo integralmente nonostante la sua monumentale e impegnativa lunghezza; ma sono parole che per il loro enorme pur se militante e divisivo valore intellettuale non possono andare assolutamente smarrite, o dimenticate, bensì gelosamente tramandate fosse anche solo per provocare l’animo di chi ancora italiano voglia e sappia considerarsi.
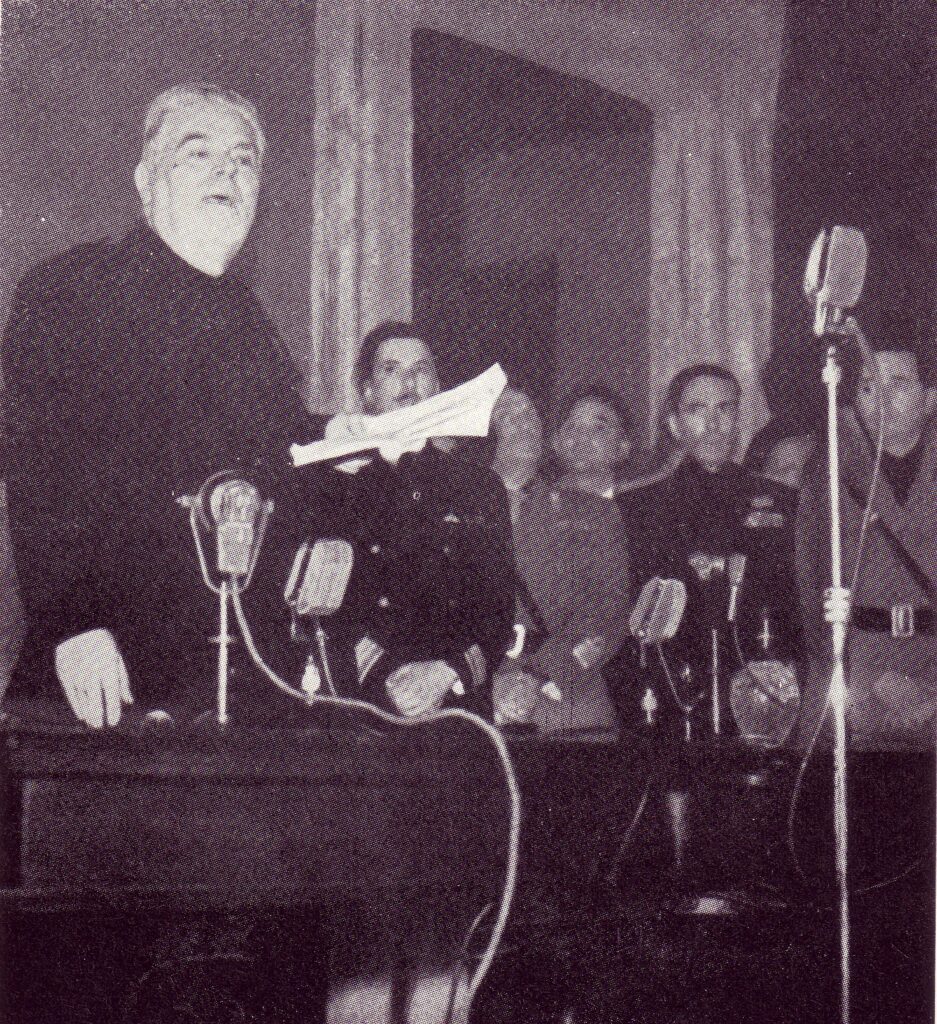
A.Martino
Questo discorso si rivolge a tutti gli Italiani che
hanno un’Italia nel cuore: un’Italia, che non sia nome vano e retorico, ma
qualche cosa di vivo e operante nel pensiero e nella volontà. Parlo come
fascista, quale son fiero di essere perché mi sento profondamente italiano, e
perciò parlo prima di tutto come italiano che ha qualcosa da dire a tutti gli
Italiani, fascisti o non fascisti, fascisti della tessera e fascisti della
fede. Dico fascisti della tessera e fascisti della fede, perché ho sempre ritenuto
che la distinzione fosse necessaria per non scambiare il principio e l’ideale a
cui s’intende aderire e che può essere la sorgente della nostra fede e della
nostra forza, con le materiali deviazioni che del principio e dell’ideale sono
flagranti falsificazioni e qualche volta pratici tradimenti. E ho sempre
ritenuto che tesserati e non tesserati si potesse essere tutti Italiani,
concordi nell’essenziale, ancorché dissenzienti nelle forme della disciplina
politica: Italiani tutti e perciò tutti virtualmente fascisti, perché
sinceramente zelanti di un’Italia che conti nel mondo, degna del suo passato. E
voglio dire subito che di due cose sono e sono stato sempre profondamente
persuaso: che molti, per vari piccoli motivi, amano dirsi fascisti e tengono
alla tessera, i quali non operano né parlano né sentono da fascisti- e
viceversa molti, moltissimi non curano d’iscriversi al Partito, i quali
sentono, e parlano, e operano da fascisti sul serio, ancorché rimangano
talvolta intricati in ideologie inconsistenti e fallaci, annidate nel loro
cervello come quei tanti pregiudizi che ogni uomo non riesce ad espellere,
ingombro più o meno innocuo al carattere e al pratico operare.
Una rivoluzione prima di essere riordinamento totale, politico e sociale, è
un’intuizione, un’idea, una ispirazione profonda di tutta la vita morale: una
ispirazione che praticamente s’impone in forme violente, che possono dare
l’apparenza degli improvvisi cambiamenti dei pensiero, delle istituzioni, del
costume e delle norme giuridiche; ma in sostanza e in verità opera lenta,
graduale, nel segreto della vita dello spirito, attraverso la formazione delle
coscienze che procede per tappe talvolta secolari. Tutte le grandi rivoluzioni
hanno avuto martiri ed eroi, ma hanno pure avuto tiepidi proseliti, pigri
assertori, ipocriti, ingenui o profittatori.
Basta pensare alla corruttela degli ordini monastici, sorti e retti sempre da
una sublime passione per la vita superiore dello spirito. E mi piace notare che
quelli che si scandalizzano dei cattivi esempi che talvolta purtroppo ci
vengono da questo o quello dei molti e forse troppi organizzatori della grande
massa del partito, mi dan l’aria degli scervellati, che in tutti i tempi si son
lasciati sfuggire l’importanza ed efficienza storica delle grandi idee perché
queste idee non le hanno sapute vedere se non gli uomini che le
rappresentavano. Ma, se non altro, la necessità quotidiana del «cambio della
guardia» ammonisce ogni giorno che altro è la persona, altro l’idea che alla
persona conferisce valore e autorità.
Queste cose io le dico, ben inteso, non perché il Fascismo abbia da scusarsi di
errori di cui oggi, nel momento della grande prova, gli si possa chiedere
conto, ma perché desidero ora più che mai, poiché oso di rivolgere il mio
discorso a tutti gli Italiani, apparire come sono: sgombro da ogni motivo di
parzialità o partigianeria; desidero essere e presentarmi non gregario di un
partito che divida, ma seguace di un concetto che possa stringere in una stessa
fede e in un concorde proponimento quanti sono veramente Italiani. Gli errori
del Fascismo sono gli errori inevitabili di ogni vasto movimento
rivoluzionario. E non vedo che bisogno ci sia di negarli. Ma al di là dei
particolari, io affermo, e confido che ognuno vorrà convenire, che c’è l’essenziale
del Fascismo; di quel Fascismo al quale tutti gli Italiani applaudirono nel ’22
quando Mussolini levò i suoi gagliardetti e chiamò intorno a sé tutto il
popolo, di tutti i partiti; quel Fascismo, al quale gli Italiani non sapranno
mai rinunziare.
Questo essenziale è, prima di tutto, una grande Italia, quale può essere
soltanto se stretta in una forte compagine politica, ossia in uno Stato che
abbia la coscienza del suo diritto e della sua forza, del suo passato e del suo
destino, e potente volontà realizzatrice, e perciò potenziatrice e
disciplinatrice delle energie nazionali, individui e classi sociali, in un
ordine di giustizia fondato sul principio che l’unico valore è il lavoro: il
lavoro umano che è attuazione della vita spirituale nel complesso de’ suoi beni
economici e delle sue idealità etiche. Questa grande Italia, questa Patria che
gli Italiani devono far grande contro le avversità della natura e degli uomini,
questa è stata dalla guerra del 1915-18 l’ardente passione di Mussolini: la passione
che egli ha riaccesa nel cuore degli Italiani, i quali nella sua possente voce
risvegliatrice degli anni cupi dei dopoguerra e della vittoria tradita e
defraudata, riudirono l’antica voce dei padri del Risorgimento e delle epoche
che questo avevano preparato: la voce dei profeti della Patria, che tornava
ringagliardita dalla coscienza della prima guerra nazionale vittoriosamente
compiuta e dalla memoria recente di seicentomila giovani immolatisi in un
delirio d’amore, come solamente i giovani sanno sentirlo, per questa Italia che
dai poeti, dai pensatori e dai martiri avevano imparato a conoscere come cosa
sacra. Ed ecco che a quella voce rinnovatrice della fede antica tutti si
riscossero, e si affollarono plaudenti intorno al Duce. Il quale, fin dal primo
giorno, tra il consenso universale, poté pronunziare il de profundis di quella
falsa libertà, di quella bastarda tirannica libertà che era la libertà del
regime parlamentare. Noi che udimmo alla Camera, al Senato il discorso del 16
novembre 1922, abbiamo ancora presenti alla memoria le facce compunte, tra
vergognose ed esterrefatte, dei vecchi paladini della squarquoia Italiana che
cadeva, di quei testimoni muti di una pseudo-libertà che veniva sotterrata per
sempre, mentre irrefrenabili scoppiavano applausi della maggioranza sorpresa
insieme e giubilante della coraggiosa negazione e dell’annunzio di una nuova
vita politica.
Mi sia consentito di ricordare un mio scritto del 15 dicembre 1917, nel quale,
dopo Caporetto, quando l’Italia si era riavuta da quel primo subitaneo
sgomento, affermavo che «un’Italia destinata a morire per effetto di una
disfatta militare non sarebbe stata, se mai, degna di vivere. Non sarebbe stata
già un popolo fatto per vivere a libero Stato, sì veramente, come amano
dipingerci i nostri nemici, quasi un’accozzaglia di uomini senza disciplina di
sorta (senza disciplina politica, perché senza disciplina morale e religiosa) e
senza capacità di serio lavoro scientifico (che è metodo, ed organizzazione),
quantunque non privi di ingegno artistico e di sporadica genialità». E
aggiungevo: «Orbene, se l’Italia non fosse stata altro che questo; se il suo
Risorgimento nel secolo XIX non fosse stato più che l’opera di fortunate
circostanze sfruttate dall’accorgimento individuale di pochi uomini, senza
radici nella storia e nell’animo popolare, e però senza sostanza; se lo Stato
quindi non si fosse dovuto considerare altrimenti di una baracca fabbricata e
tenuta su alla men peggio per dar modo ad alcune centinaia di avvocati di
riunirsi in Roma a far chiacchiere o gli interessi di questo o quel gruppo, di
questa o quella classe; oh per Dio! non questa era l’Italia immortale che
imparammo ad amare ardentemente nelle pagine dei nostri grandi».
L’Italia non soggiacque a Caporetto; e il Piave e Vittorio Veneto ebbero il
loro sbocco nella Marcia su Roma; e quella baracca fu scrollata e spazzata via.
E i veri liberali che sentivano la nausea di quella baracca, furono contenti. I
liberali dell’Aventino e della posteriore «religione della libertà» diventavano
sempre più malinconici nell’accorata nostalgia del fugato ed evanescente
fantasma della libertà parlamentare. Con questa infatti essi scambiavano la
sola libertà che esista, la eterna libertà, che è dello spirito nella sua vita
interiore, alla quale le contingenti strutture della organizzazione vengono
apprestando le varie forme di esistenza a volta a volta giustificate da
particolari ragioni storiche, tutte inadeguate e talvolta anche contrarie
all’essenza della stessa libertà: le quali, ad ogni modo, fatte il loro tempo
periscono.
E spesso non riescono nemmeno ad attecchire perché create artificialmente ad
imitazioni di Stati con diversi costumi, diversa educazione, diversa storia.
Comunque, tali forme non sono eterne categorie dello spirito, ma semplici
strumenti che servono finché servono e poi si logorano e si buttan via.
Altro è la libertà, altro il liberalismo: quella, ripeto, è eterna; questo non
si può irrigidire in una forma storica senza vuotarsi del suo spirito
originario e isterilirsi in un meccanismo funesto; dal quale i sinceri amatori
della libertà non possono non desiderare che la Nazione venga liberata. E chi
si indugia a piangere sulle rovine di Cartagine, e non ha occhi per vedere la
grandezza di Roma, è uno spirito romantico che alla lunga riesce ridicolo. Il
parlamentarismo è morto in Italia e bisogna che anche i non fascisti, anche i
comunisti anelanti in segreto non si sa quale libertà utopistica, ne sappiano
grado a Mussolini.
Noi che non siamo di ieri, abbiamo viva nella memoria la cronaca della
corruttela parlamentare che venne inchiodando il nostro paese dal ’76 in poi
alla croce di un sistema dissolvitore di ogni schietto spirito politico, voglio
dire del concetto e sentimento dello Stato e del suo valore, e quindi di ogni energica
volontà di elevazione e di grandezza. E chi è giovane, se vuol sapere quale
vita morale, quale carattere allignasse nella morta gora del politicantismo
elettoralistico di un tempo, legga il Viaggio elettorale di De Sanctis, che è
pittura artisticamente ancor viva, e documento fedele del costume imperante
nella vita pubblica italiana di un tempo.
Ma quel liberalismo non è morto soltanto in Italia. Gli Stati che si dicono
democratici per avversione ai nuovi Stati totalitari dimostratisi via via sempre
più incomodi e pericolosi, hanno trovato il modo di rintuzzare ogni velleità
liberalesca individualistica con la forza stritolatrice dei raggruppamenti
economici. La libertà in cotesti Paesi è a terra, e non può aver salvezza, come
sempre più apertamente si riconosce in linea teorica e nella prassi politica,
se non nell’assetto corporativo; ossia nell’idea che il Fascismo, primo,
proclamò in Italia come l’ordinamento più congruo alle insopprimibili tendenze
dell’individualismo, quando questo non sia concepito in funzione di atomi
sociali affatto inesistenti, ma come l’individualismo degl’individui reali,
che, pur essendo sempre individui, sono dalla loro attività economica, come
forze produttrici, specificati, raggruppati, stretti in sistema organico, la
cui unità, fatta consapevole del comune interesse, è lo Stato. E questo Stato
nella sua forma corporativa non è il gran gerente degli interessi materiali
della complessa azienda economica di tutti i cittadini, ma la personalità
centrale creatrice del diritto di tutti i gruppi e di tutti gli individui, e,
come ogni personalità, dotata di un valore etico assoluto e autonomo: sistema
della libertà.
Tutti i popoli, si può dire, si orientano ormai verso questo ideale dello Stato
corporativo, che è in cammino. Processo di formazione difficile, che oggi è
appena al suo inizio.
Ma sentono tutti che esso è l’ avvenire. Si modificherà, si snellirà facendosi
sempre più aderente alla realtà sociale ed economica; ma tornare indietro non è
possibile. E forse l’Europa ritroverà se stessa, la sua forza e la sua missione
direttiva nel mondo, quando si sarà resa conto di questo profondo principio di
vita che è nel regime corporativo.
Comunque, se questa rivoluzione fascista che è l’Italia di Vittorio Veneto
aspirante con la coscienza del suo diritto a riscattare la sua vittoria dalla
prepotenza usurpatrice di Versaglia, è la liquidazione del regime parlamentare
e l’avviamento al corporativismo, io non so vedere nel Fascismo altro che il
potenziamento di questa nostra Italia: dell’Italia di Dante e Machiavelli, di
Cuoco e di Mazzini, della tradizione nazionale e realistica, dell’Italia
destinata ad adempiere una sua missione nel mondo: quell’Italia, che gli
Italiani del nostro secolo ebbero prezioso retaggio dai loro padri dell’Ottocento,
come lampada da alimentare col meglio di se stessi: lavorando, studiando,
facendosi onore dentro e fuori i confini della Patria, conciliandosi
l’universale rispetto con la serietà del carattere e del costume, con la
risolutezza e tenacia dei propositi, con la disciplina delle armi, con
l’ardimento necessario nelle competizioni mondiali, con l’austerità della vita
che ben si può accompagnare con la genialità dello spirito luminoso della
razza.
Questa Italia ha certamente trovato nella voce di Mussolini una potente
espressione del suo carattere immortale; ma questa Italia è pur quella che è in
cima ai pensieri di ogni Italiano, anche di quelli che erano già troppo avanti
negli anni per sentire in quella voce un grido sgorgante dal loro stesso petto,
anche di quelli che eran fanciulli quando quella voce tuonò è non potevano
ancora sentirne l’accento profondo. Di ogni Italiano, che voglia essere
Italiano.
Consentitemi questa riflessione. Italiani non si è per diritto di nascita.
Ognuno è quello che merita di essere, ed ha quello che merita di avere. Quello
che si può presumere di possedere dalla nascita, bisogna conquistarselo col
proprio merito, col proprio lavoro, con i propri sforzi. Perciò Italiani sono
veramente quelli che vogliono essere Italiani.
E procurano di saper bene, prima di tutto, che cos’è questa Italia: Roma, e
Roma non soffocata dai barbari, ma educatrice di tutti i barbari, di qua e di
là dalle Alpi per ogni terra che sarà, dopo la Grecia e Roma, l’Europa; e poi,
la Chiesa cattolica, elaboratrice e propagatrice mirabile dell’Evangelo, la più
radicale riforma e la più feconda e vitale mai stata fatta della vita
spirituale dell’uomo. E poi il Rinascimento, l’esplosione più potente che la
storia ricordi del genio umano, ossia della sua potenza creatrice (nell’arte,
nella scienza, nella politica, nella economia); onde si varcarono le mal
vietate colonne d’Ercole e l’uomo si impadronì di tutta la terra e instaurò
quel regnum hominis che è il mondo moderno, tutto compenetrato, avvivato e
illuminato dal pensiero dell’uomo. E poi il Risorgimento, che fu la rivelazione
di tutte le virtù latenti di questo popolo antico e sempre giovane,
sopravvissuto alla divisione e alla servitù politica per forza del suo
intelletto, per la profondità dei suo sentire, per l’irriducibile coscienza
della sua unità, per l’incontenibile slancio del suo spirito, ansioso sempre di
venire a vita di Stato, e di essere ancora e sempre Italia: la nostra Italia
sognata dai poeti e preconizzata nei suoi termini e nella sua etica attualità
dal primo e maggiore di essi, l’Italia meditata da’ suoi pensatori, attestata e
consacrata col sangue dei suoi martiri e poi da ultimo risorta come per
miracolo, per opera di uomini di tutto il mondo ammirati per la costanza della
loro purissima fede, per l’energia della loro azione ardimentosa, per
l’accorgimento e la sapienza della loro politica. Non c’è, in verità, nazione
al mondo la cui origine e formazione possa vantare tanta gloria di martirio e
di sacrifizio, e di valore guerriero e di patriottismo, e tanta ricchezza di
umanità e di vita morale: motivo di orgoglio per i suoi, motivo di ammirazione
per gli stranieri. Quanti libri di ricerca animata di amore incondizionato come
culto, in Inghilterra e in America, per Mazzini e Garibaldi!
Italia grande e immortale, questa per cui ci tocca di vivere e di morire. Una
Italia a cui gli stranieri si inchineranno sempre e si inchinano nel segreto
del pensiero anche quando l’interesse li tragga a schierarsi contro di lei. Ma
è I’Italia che deve esistere nel mondo come una realtà viva e presente e non
come un semplice ricordo: deve, come i monumenti più pregiati degli antichi,
perpetuarsi nell’amore e nella culla dei viventi, a cui spetta di conservarli.
Oggi, Italiani, siamo al punto. Oggi come non mai, da che siamo risorti a Stato
e abbiamo detto: « Ci siamo », gli occhi dello straniero sono sopra di noi. Non
basta che il nostro esercito, la nostra marina, la nostra aviazione abbiano
fatto prodigi di valore; il nemico, che ha assaporato l’amarissimo gusto delle
disfatte, si è rovesciato con tutto il peso immane delle sue macchine brute
sopra questa più debole parte del fronte avversario tenuto da noi; ha fatto
scempio delle nostre città; ha incrudelito contro i domestici focolari, sopra
le nostre donne, i nostri vecchi, le nostre tenere creature: ha sperato,
presume di fiaccarci e piegarci col terrore e l’orrore di un flagello, che
assume proporzioni d’uno di quei flagelli che si scatenano dalla natura e
innanzi ai quali l’uomo fugge esterrefatto, quando non sia sterminato. Oh la
insana furia devastatrice che ha imperversato sulla bella Palermo, perla del
Mediterraneo, cuore generoso dell’eroica Sicilia. La notizia dell’ultima
spettacolosa e infame incursione sopra di essa mi giungeva con le bozze di un
bellissimo libro, che ora si ristampa: Palermo cento e più anni fa di Giuseppe
Pitrè, del siciliano più amante della Sicilia che ci sia mai stato, del più
siciliano dei siciliani, scrittore di grande dottrina e di grande passione,
autore di una ciquantína di volumi, in cui vive eterna la vecchia Sicilia, che
portò alla patria comune l’ardore de’ suoi entusiasmi, la tempra ferrea del suo
carattere, la fierezza della sua anima indomita, l’acutezza dei suo ingegno, e
una grande fede nell’Italia madre. Se Giuseppe Pitrè avesse vista la sua città
natale, la città dove visse tutta la vita, la città da lui investigata in tutte
le sue strade, le sue chiese, i suoi palazzi, nella vita pubblica e nella
privata, nei suoi signori e nel suo popolo, e amata come la casa dove siamo
nati e dove risorgono ad ora ad ora tutti i ricordi domestici intessuti nel
fondo della nostra anima; se l’avesse vista devastata dai novissimi barbari, e
le case abbattute e le strade desolate dalle macerie e dalla morte, oh, come ne
sarebbe schiantato! Ma il suo schianto è il nostro schianto: per Palermo, per
Genova, per Napoli, per Messina, per Cagliari, per Trapani, per le città più
duramente colpite. La risposta a questi eroi dello sport in cui non splende una
luce di onore militare, l’han data le nostre popolazioni bombardate,
mitragliate, tormentate fisicamente e moralmente di giorno e di notte per mesi
e mesi tra i disagi e le miserie inenarrabili di ogni genere, conseguenti a
ogni incursione, tra il terrore della morte e le tribolazioni degli
sfollamenti, nella fame e nella sete, maledicenti sempre al nemico spietato,
anelanti sempre alla salvezza della Patria.
Non un grido di protesta contro i presunti responsabili della guerra; non un
tentativo di farla comunque finita; non un segno di stanchezza e prostrazione
degli animi.
Spettacolo ammirevole e altamente commovente che incute rispetto agli
stranieri, che fa riflettere i nemici e deve far riflettere noi stessi. I
nemici rifletteranno forse che non è questa la via della vittoria perché non è
questa la via dell’onore. Noi, da parte nostra, dobbiamo riflettere che di
questo popolo che meraviglia il mondo con la sua eroica capacità di resistenza,
noi Italiani dobbiamo essere degni per l’animo impavido che non trema si
fractus illabatur orbis; degni per la coscienza del dovere che c’incombe di
assistere con cordiale solidarietà tutti questi nostri fratelli che più
soffrono per la Patria comune; di sorreggerli con l’esempio e con la parola;
con l’esempio di abnegazione e devozione alla causa per cui si combatte e per
cui si può chiedere il sacrifizio anche delle cose più care: con l’esempio
della fierezza con cui devono essere sfidati i pericoli e sopportati i più
dolorosi disagi se questi sono inevitabili per la vittoria; con la parola
animatrice, sdegnosa fino allo scrupolo d’ogni confessione delle nostre
debolezze, dei nostri difetti, di tutte le difficoltà, tanto maggiori quanto
più sentite e sciorinate agli altri e a noi stessi: la parola che sia sempre
seminatrice di fede e non insinuatrice di pessimismo. Tutti gli Italiani che
riflettono, che pensano, che in questa lunga vigilia della vittoria, quando non
abbiano più urgenti cure di lavoro e di pratici problemi profittano del celeste
dono dell’intelligenza, che è sempre critica e tende sempre alla satira o
all’invettiva, per farne materia di analisi, di considerazioni più o meno
oggettive, come si dicono, e ad ogni modo irresponsabili, sopra l’andamento
della guerra, sopra le sue origini, sopra le sue difficoltà, sopra gli errori commessi,
sopra l’esito finale, non sono gl’Italiani degni del popolo che soffre e non
diserta. Gli Italiani che domandano ogni giorno i conti, che vogliono vedere
freddamente come vanno le cose, che hanno da dire qualche cosa su tutto quello
che si fa, che si mettono insomma al di sopra degli avvenimenti, poiché
esercitare l’intelligenza è sempre un mettersi al di sopra delle cose e trarsi
fuori dell’azione, per fare la parte di spettatore che giudica senza
compromettersi; questi falsi Italiani devono aprire bene gli occhi e por mente
che non è punto vero che essi non si compromettono e non agiscono. Essi
compiono una loro azione, un’azione vile di devastazione delle energie morali
del popolo che soffre e combatte, essi assumono una tremenda responsabilità: la
responsabilità del tradimento. Nessun Italiano ha oggi il diritto di dire:
“Questa non è la mia guerra; io non l’ho voluta.” Non c’è nessuno in
Italia che prenda parte alla vita della nazione in modo più o meno attivo, che
non abbia voluto la guerra in cui la Patria è impegnata.
L’avrà voluta indirettamente se non per diretta decisione. Poiché una guerra
come questa, in cui sono impegnate, in un modo o nell’altro, tutte le forze del
mondo, una guerra che gli storici non potranno spiegare senza risalire a secoli
di eventi che l’hanno preparata, maturando lentamente attraverso tutto lo
svolgimento dell’imperialismo anglo-sassone, la concentrazione e il
potenziamento della grande industria, la risurrezione e l’organizzazione
dell’Asia, il travaglio sociale del lavoro e pensiero europeo nella
rivendicazione delle classi lavoratrici e delle utopie che ne son derivate; una
guerra di queste proporzioni che è sotto i nostri occhi una delle maggiori
crisi della storia del mondo, non è concepibile come risoluzione arbitraria di
uno o più individui. Tutte le previsioni umane sono state via via superate;
perché chi operava ed opera non è l’umano accorgimento, che negli individui
pare arbitrio derivante da personali programmi contingenti. Opera un agente
molto superiore, che è pure umano ma fa pensare a Dio; o se questo nome che qui
non si nomina invano, vi pare troppo alto, dite pure la Provvidenza o anche la
logica, o la necessità della storia. Fata trahunt; e ogni recriminazione
nel pericolo è viltà. E’ pavida ansia di mettersi in disparte, mentre
l’incendio infuria ed è dovere di tutti adoperarsi a spegnerlo.
Da questa viltà non è facile guardarsi. Ma tanto maggiore perciò il dovere di
non cadervi per leggerezza, irriflessione, perfido gusto di chiacchierare e far
pompa del proprio acume. Massimo dovere questo per gli Italiani che hanno per
lunghi secoli scontato questo difetto della loro più alta virtù, voglio dire
l’intelligenza. Della quale abusarono in passato, dal Rinascimento in qua,
staccandola dalla vita per darle agio di spaziare liberamente nella letteratura
e nell’accademia; e dopo i martiri del ’99, del ’21 e del ’31 ci volle
l’apostolato assiduo, ardente di spirito religioso di Giuseppe Mazzini; ci
volle anzitutto la rivoluzione spirituale operata, con quella mano poderosa che
pareva non aver nervi, da Alessandro Manzoni, per riportare l’intelligenza alla
serietà religiosa della vita: dove non c’è parola, non c’è sentimento che non
pesi in eterno col suo valore, e non c’è perciò attimo della vita di cui l’uomo
non debba render conto anche nel segreto della sua coscienza.
Né recriminare, né far profezie almanaccando sull’avvenire che resta sempre
sulle ginocchia di Giove anche per quei pochi che conoscono della politica
tutto ciò che ai molti sarà sempre impossibile conoscere. Vinceremo? Non
vinceremo? Entrambe le previsioni sono deleterie se fatte come di eventi
oggettivamente necessari, i quali accadranno, quale sia la nostra personale
condotta.
Diventando infatti sorgente di quel facile ottimismo e di quel non meno
facile pessimismo che non costano nulla oltre un piccolo gioco di parole e di
calcoli più o meno probabili, ma sono ugualmente funeste come tentazioni
rallentatrici e disgregatrici della volontà. Io sono stato sempre ottimista. Ma
l’ottimismo sano e legittimo non riguarda gli avvenimenti che sono nelle mani
di Dio, ma s’irradia dall’intimo della nostra coscienza e della nostra persona:
è l’ottimismo di chi crede, e con la sua fede crea il bene a cui si aspira; o,
che è lo stesso, concorre a crearlo.
Vincere l’Inghilterra, l’esecrata tiranna di ieri, la tiranna certamente
spietata di domani, si, la dobbiamo vincere; e la vinceremo, se la vorremo
vincere a qualunque costo; se non ci stancheremo di combattere, se resteremo
fedeli ai nostri impegni verso gli altri e verso noi stessi, se in ogni ora del
giorno, in ogni istante ci ricorderemo di questo nostro dovere. Ma questa
vittoria è una vittoria secondaria e subordinata; la principale è un’altra
vittoria, condizione della prima, e sola veramente essa è quella che dobbiamo
ottenere giorno per giorno costantemente, sopra noi stessi, vincendo tutte le
tentazioni allettatrici della viltà, reagendo con cuore indomabile ad ogni
avversa fortuna, tenendo sempre alta la bandiera: la bandiera della Patria, che
è la bandiera della nostra coscienza, della nostra morale esistenza. E’ la
vittoria che dipende da noi, e che nessuno ci potrà strappare dalle mani se noi
la terremo in pugno con tutto il vigore dell’anima, come la nostra dignità alla
quale nessuno vorrà mai sopravvivere.
Ogni popolo ha innanzi una vittoria che è il suo dovere, e una vittoria che è
il suo diritto. Il quale non suole mancare a chi compie il proprio dovere. E
quando fallisse, quando tutto fosse perduto tranne l’onore, o prima o poi, la storia
ce l’insegna, la giustizia si compirebbe perchè un popolo che serbi intatta la
coscienza della propria dignità, e la purezza della propria razza, che non
smarrisce la nozione di quello che è, e dev’essere, potrà vedersi a un tratto
oscurare il firmamento sopra di sé; ma a breve le stelle torneranno a brillare
nel cielo; ed egli nella sua coscienza tranquilla saprà ritrovare la sua via.
Ed i nemici continueranno ad inchinarsi alla nazione che anche attraverso la
sventura abbia dimostrato la sua natura immortale. L’importante dunque è aver
fede nella vittoria: nella essenziale vittoria che dipende dalla nostra stessa
fede ed è infatti nella nostra volontà. Essa sola può farci meritevole
dell’altra. La cui previsione è molto difficile per le ovvie ragioni che tutti
sanno; ma anche per una considerazione che per solito sfugge, e che deriva
dalla stessa difficoltà di determinare il significato reale della parola «
Vittoria ».
La quale è bensì la conclusione della guerra guerreggiata; ma può essere una
conclusione militare, per cui una delle due parti contendenti è costretta a
deporre le armi; ma può intendersi anche come una conclusione politica, la
quale è complessa e risulta da una convergenza transitoria di interessi che
provochi magari una Carta atlantica sottoscritta con la piena coscienza che gli
eventi, andando al di là del preveduto, potranno buttare quella carta in fondo
allo stesso Atlantico. Meglio dunque attenersi a Dante, che colloca in
Malebolge indovini e astrologhi condannati in eterno a portare il viso
stravolto sulle spalle, come Tiresia e come Anfiarao che ha fatto petto delle
spalle perché volle veder troppo davanti; di retro guarda e fa retroso calle.
Secondo Dante, questo strologare sul futuro è un portare passione al giudizio
divino. L’uomo, che abbia senso di vita morale, deve anche lui chinare la
fronte e riconoscere il massimo Fattore, e tacere, ma tenendo virilmente il
proprio posto, disposto a vivere, disposto a morire.
Senza questa religiosa disposizione dell’animo, l’uomo si sbanda, e diventa
pagliuzza in balia del vento; ma non è più uomo, come può soltanto avendo un
carattere, un volere, un dover, un punto che è il suo centro, la sorgente della
sua vita e di ogni suo pensiero. E vorremmo noi negar la fiducia a Dio se noi
avremo fatto tutto il nostro dovere? Potremo noi sospettare che i valori dello
spirito che noi realizziamo, vadano perduti? Potremo noi temere che questa
Italia immortale, che splende agli occhi di tutti nel mondo, se è viva negli
animi nostri, perisca sotto i colpi di ebbri piloti di fortezze volanti?
Potranno cadere anche le mura e gli archi, che sono rimasti per millenni a
testimoniare la maestà di Roma e la barbarie dei suoi nemici; potranno, in
questa lotta del nuovo continente restio e sordo all’azione incivilitrice
dell’Europa e cioè di Roma, i nuovi barbari compiere l’azione devastatrice
degli antichi: ma ci può essere uomo al mondo, di qua o di là dall’Oceano, che
pensi di far tramontare la gloria di questo Campidoglio fulgente? Che pensi che
il Sole possa qualcosa urbe Roma videre maius? E dico Roma antica e moderna; e
dico il Comune italiano e il Rinascimento; e dico il Risorgimento. Le città
nostre potranno essere distrutte; ma saranno riedificate perché il popolo
stesso che le ha fatte nascere le farà rinascere; potranno anche esser mutilate
o annientate le chiese e i monumenti, che facevano ricercare da ogni uomo colto
la nostra terra di civiltà sempre viva nel genio che le produsse; ma gli stessi
avanzi parleranno e la memoria non potrà perire; e basterà mantener viva la
coscienza della grandezza italiana e del bestiale vandalismo di chi a un tratto
volle dimenticare che i monumenti di codesta grandezza erano patrimonio
spirituale di tutti gli uomini del mondo; anche di quelli che, l’Italia proprio
l’Italia, con Colombo trasse dagli oscuri e ignorati ipogei della storia, e
accomunò alla vita dell’Europa elevandoli alla luce della nostra civiltà nella
solidale collaborazione di tutte le nazioni disciplinate da un’altra religione
umana, dalla ricerca scientifica spiritualizzatrice della materialità della
natura che essa sottomette a mano a mano alla signoria dell’uomo, e della
riflessione filosofica che fa l’uomo padrone di sé medesimo. Né gli Americani
si può dire che non lo sapessero, se, come ognuno ricorda, non contenti di
venire da noi ad ammirare e studiare, hanno tanto fatto e pagato per racimolare
le briciole del grande banchetto italiano di storia ed arte, e arricchirne i
loro musei e le loro biblioteche. Italiani, siate voi fedeli alla madre antica;
disciplinati, concordi, memori della responsabilità che viene a voi dall’onore
di essere Italiani; risoluti di resistere, di combattere, di non smobilitare
gli animi finché il nemico vi minacci, e dubiti della vostra fede e dei vostro
carattere. Le dispute e le dissensioni a dopo. A Calatafimi Garibaldi gridò a
Nino Bixio: Qui si fa l’Italia o si muore. Quel grido non è spento e la grande
voce dell’Eroe risuona, deve risuonare oggi nel nostro cuore: Qui si salva
l’Italia o si muore. Noi che siamo sulla china degli anni, e siamo vissuti
dell’eredità dei padri, sentendo sempre l’obbligo nostro di conservarla, questa
eredità, e per quanto era da noi di accrescerla col nostro lavoro e con ogni
sforzo di buona volontà, non sappiamo pensare che essa non abbia a potersi
consegnare nelle mani dei giovani, capaci di sollevarla in alto col vigore
delle loro braccia al di sopra delle passeggere discordie, dei piccoli
risentimenti settari, delle ansie e de’ rischi dell’ora presente, al di sopra
di tutte le umane debolezze, per tramandarla ai nepoti, sempre viva, splendida
della sua eterna giovinezza.
Con questa fede nella Patria immortale, noi mandiamo il nostro saluto di
riconoscenza e di amore agli eroici soldati di terra, di mare e del cielo; e
continuiamo a guardare alla Sacra Maestà del Re, silenzioso e sicuro nella
semplicità austera del gesto e della parola; a guardare negli occhi del Duce,
che conosce le tempeste e ci ha dato prove del coraggio che le fa vincere,
della indomita passione con cui si deve guardare al destino.
Viva l’Italia!













Lascia un commento